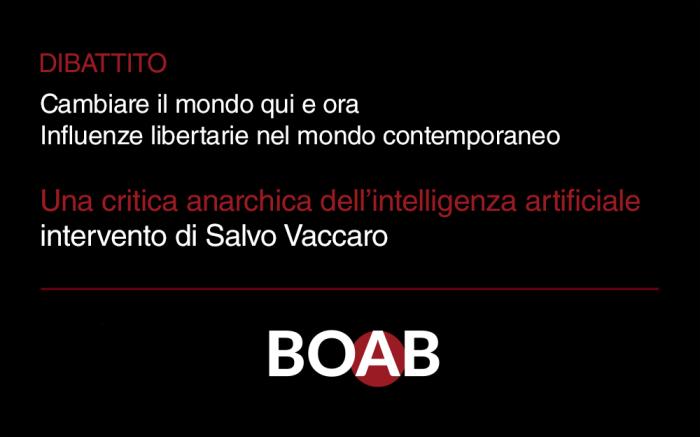Una critica anarchica dell’intelligenza artificiale
di Salvo Vaccaro
Diciamocelo francamente: l’unica, vera, rivoluzione planetaria alla quale abbiamo assistito negli ultimi 40 anni è la stata l’affermazione del World Wide Web, grazie all’avvento delle tecnologie digitali di origine cibernetica e computazionale, di cui l’IA è l’ultimo passaggio in ordine di tempo. Ha radicalmente trasformato le esistenze umane, divenendo ben presto il perno intorno al quale ruota ogni cosa. Proprio per questo ritengo che indietro ormai non si possa tornare – a meno di un evento catastrofico, quale una guerra nucleare – e che ciò che non ci piace (in senso politico) vada contrastato non in termini “luddistici” (qualunque cosa voglia dire un luddismo applicato macchine virtuali ma con dorsali fisiche ben rintracciabili: infrastrutture, data center, satelliti…), bensì in termini “dadaistici”, con il rovesciamento ironico della sovversione ludica – “sarà una risata che vi seppellirà” – e la trasfigurazione “surrealista” che muta design e obiettivo d’uso.
Dobbiamo agli scienziati del Cern di Ginevra – Tim Berners-Lee per primo – la gratuità di accesso al web dato il suo rifiuto cosciente di intestarsi un copyright che gli avrebbe fruttato una ricchezza inimmaginabile; dobbiamo agli universitari americani la gratuità degli scambi via mail; dobbiamo alla forza emancipatrice della comunicazione virtuale la libertà di movimento e di mobilità che incrementa l’opportunità di stringere reti sempre più ampie e plurali (se lo si vuole). Per i primi vent’anni, un certo libertarismo – non solo nel senso americano del termine, carico di equivoci per noi europei – ha rappresentato la cifra di un’invenzione che oggi attestiamo come una rivoluzione nel modo di vivere, di relazionarci, di informarci, di agire sia nel mondo corporeo che nella realtà virtuale. L’unica, prettamente tecnologica, e quindi politica e sociale per definizione, forse addirittura antropica per via dell’impatto sulle identità degli umani sulla terra, dei quali ormai quasi la metà dis-individua se stesso tra un sé corporeo e un alter ego virtuale, con interessanti risvolti sulla reciproca tensione e sul peso di ciascun sé negli equilibri esistenziali di ognuno/a.
È noto come gli attuali ricchi-e-potenti delle Big Tech – individui in carne e ossa il cui patrimonio esorbitante consente loro una forza d’urto in termini finanziari e di influenza politica tali da ricattare intere nazioni e interi stati del pianeta – alla fine del secolo scorso stessero sull’orlo del clamoroso fallimento delle loro società, Google e Amazon fra le altre. Da tale rischio scatta la strategia di appropriazione del web, della eliminazione della ventata libertaria (in senso affine al significato che ne diamo noi europei) in favore di una rivincita del libertarianismo americano (giusto per differenziare i termini) proteso alla conquista proprietaria del web e delle sue applicazioni.
La chiave di volta di tale contro-processo proprietario e pertanto illibertario nella nostra prospettiva è l’uso gratuito dei dati di cui le Big Tech si appropriano senza costi né oneri. Una cattura camuffata da cessione gratuita da parte di ogni utente in cambio dell’accesso al web, alle piattaforme proprietarie, alle applicazioni inventate, soprattutto agli spazi social in cui l’individualizzazione solitaria e solipsistica del rapporto tra sé e schermo viene spacciata per socializzazione (virtuale e poco corporea).
Non solo la miniaturizzazione delle tecnologie ha consentito l’accelerazione di un processo di digitalizzazione dell’intera società, specialmente per le generazioni degli ultimi vent’anni, grazie all’introduzione dello smartphone user friendly, ma l’architettura intima e costitutiva delle tecnologie digitali si fonda su due architravi che attivano una produzione di ricchezza dal punto di vista commerciale e di controllo delle società dal punto di vista politico. Si tratta della datificazione (datafication) e della profilazione (profiling).
Ogni secondo in cui utilizziamo uno strumento digitale, per tutto l’arco di vita potenziale, a partire dagli otto anni di età (ultimi dati sociologici), la produzione di dati relativi all’utente è immensa, inimmaginabile, misurabile solo in aggregati mostruosamente enormi che gli algoritmi digeriscono ed elaborano sino a tracciare e unificare ogni nostro comportamento digitale. Il risultato è la configurazione della nostra identità online – più o meno coincidente con la nostra percezione del sé corporeo e con il riconoscimento altrui, il che definisce l’aggregazione sociale.
Se la datificazione consente una conoscenza sempre più perfezionata e perfezionabile dei nostri comportamenti online per diventare una formidabile arma di seduzione di massa a fini di marketing commerciale, la profilazione consente ai proprietari dei dati – che non siamo noi bensì i proprietari delle piattaforme – di poter individuarci quanto più precisamente possibile al fine di predire i nostri comportamenti futuri. Un po’ magia divinatoria, un po’ conoscenza divina, l’arma di seduzione di massa funziona al punto da provocare un potente flusso di informazioni che riescono a orientare il nostro comportamento in rapporto a scadenze elettorali, ad esempio, come dimostra il caso Cambridge Analytica in occasione della sfida presidenziale Trump-Clinton nel 2016.
Ma la profilazione viene usata usualmente per sorvegliare e controllare la conformità dei nostri comportamenti ad uno standard morale o politico che i governi autocrati – ma anche democraticamente autocratici – attivano per governarci uti singuli, individualmente e collettivamente, come ci ha insegnato Foucault quando parlava di governamentalità. Non è tanto il capitalismo della sorveglianza, a mio avviso, quanto la società del controllo, dell’addomesticamento, della disciplina bio-tecno-politica, dell’isolamento volontario nel quale siamo indotti quanto più tempo trascorriamo sui dispositivi digitali.
L’ultima frontiera delle tecnologie digitali – ma ormai sappiamo che è sempre una penultima frontiera – è l’Intelligenza Artificiale, di cui l’aggettivo è corretto, mentre appare esagerato il sostantivo. Infatti, l’IA “ragiona” come una macchina, non come un umano: la sua modalità di elaborazione dei big data immessi e memorizzati e lavorati – operazione che surclassa ogni Pico della Mirandola vivente sulla terra – funziona per correlazione statistica, ignorando bellamente grammatica e semantica del linguaggio (testuale, visivo, sonoro, ecc.), data la sua cifra binaria di base che ne struttura l’architettura di fondo. L’IA sarà capace di sostituire lavoro intellettuale umano, esattamente come le macchine industriali hanno rimpiazzato il lavoro vivo fisico e come i robot affiancheranno il lavoro umano in delicate operazioni. Ciò apporterà forse benefici a lungo termine, certo è che nella fase di transizione i cicli produttivi causeranno una disoccupazione preoccupante, vista la nostra realtà capitalistica in cui vige il predominio assolto del dio denaro come fonte di vita.
Ma perché le tecnologie digitali, l’IA da ultimo, e ciò che potrà avverarsi in futuro (anche senza cadere ossessionati nella paranoia postumana dell’egemonia macchinica sull’umano), hanno a che vedere con l’anarchismo e la pratica anarchica? Come recita il lemma stesso di anarchia, il negazionismo insito nel concetto che proviene da una cultura classica della grecità ben cosciente (già in Platone ed Aristotele, ad esempio) del rischio anarchico per ogni società in cerca di libertà e di esautorazione dell’autorità e della gerarchia politica, priva di fondamento su cui erigere la propria costruzione critica. La critica anarchica è contingente per definizione, non ha pilastri ideali cui agganciarsi stabilmente (e il suo andamento carsico nella storia del nostro spicchio di civiltà lo rivela), essa si articola su una sfida a ciò che è costituito, anche nell’immaginario sociale, e su una scommessa in una diversa organizzazione della società, possibile proprio perché sperimentata e sperimentabile. La sua identità non è data una volta per sempre, l’anarchismo non possiede un’essenza sovra-storica, diviene secondo latitudini e longitudini differenziate, seppure con intersezioni comuni. Il suo volto è crucialmente etico, sono le pratiche a disvelare un’opzione anarchica e una personalità anarchica, non certo la fede oralmente tramandata o la memorizzazione pedissequa dei classici del pensiero anarchico. E l’ethos anarchico si incarna in corpi umani, unici e irripetibili, non sdoppiabili.
È in questa giuntura che scocca l’attrito con le tecnologie digitali, le quali concorrono a disincarnare l’umano per duplicarlo nella protesi virtuale di una macchina, non più al servizio bensì asservente l’umano, che smarrisce anima e corpo per riversarla nelle operazioni macchiniche che offrono l’apparenza illusoria di una replica fedele di emozioni, sensazioni, percezioni, informazioni. Proprio ciò che costituiscono la terra di formazione del soggetto, oggi appannaggio delle piattaforme proprietarie in grado di “plasmare” gli umani-utenti orientandone l’ethos senza farsene accorgere. In gergo, si chiama nudge, la “spinta” gentile e paternalistica tipica del pensiero libertariano, che oggi assume dimensioni e pressioni più in grande (big nudging) affinché si “persuada” l’utente meno avvertito a cadere nella trappola dell’algoritmo predittivo, ossia nella forza simil-coercitiva – ma più vicina alla servitù volontaria da noi tanto analizzata in passato – di far fare cose che, in sua assenza, altrimenti non faremmo. Il che equivale alla definizione di dominio usata da Max Weber cent’anni fa. Solo che con questi dispositivi, il dominio passa attraverso la metamorfosi della libertà, e non più solo attraverso la repressione. Questa diviene solo arma di riserva, economizzandola per non renderla irrilevante per via di un uso inflattivo, mentre la prima si camuffa da arbitrio – faccio quel che voglio – venendo deprivata del limite etico: non tutto quel che voglio fare consiste nella libertà, potrebbe annullare la mia venendo meno al precetto bakuniniano. D’altro canto, l’autonomia di scelta è appunto sospinta, indotta, orientata, incanalata, quindi un’autonomia indirettamente etero-diretta in modo appunto camuffato.
Peraltro, la costituzione etica di una soggettività non è un’operazione asettica che avviene in una sorta di vuoto pneumatico, o solamente sul piano di un ideale alfieriano (chi non ricorda “volli, e volli sempre, e fortissimamente volli”). Essa avviene sul piano mondano in cui si scontrano ideali, visioni, prospettive a breve, medio e lungo termine, utopie e distopie, interessi, bisogni, desideri, che ognuno/a di noi seleziona, sceglie, elegge come propri in base a fattori cangianti, casuali, imprevisti. Così diventano “verità”, non fondate scientificamente come ipotizzava Marx per il suo socialismo, bensì pur sempre relativamente vere per noi per un tempo delimitato, infatti si può sempre mutare opinione, idea, valori di riferimento e via dicendo. Aderiamo e costruiamo al contempo una verità che si appoggia su un terreno più o meno stabile di fatti reali, storicamente accaduti, analizzati e sviscerati, dai quali ricaviamo pretese di giustizia a fronte di iniquità sconvolgenti e intollerabili. Ma cosa può succedere quando l’IA ci presenta non-fatti presentandoli come verità reali? Finzioni e falsificazioni sono sempre esistiti, c’è sempre stato un lavoro di verifica che si appoggia sulla riconoscibilità raggiungibile di una determinazione del fatto storicamente accertato, quindi accaduto realmente sul quale far ripartire un ragionamento sul peso di verità che esso assume nell’incrocio con le nostre coordinate di pratiche di valorizzazione. Tutto ciò viene spiazzato dal mondo virtuale costruito sulla dimensione della post-verità, nella quale il fatto viene altrettanto costruito come una notizia, un’immagine, un sonoro fabbricato artificialmente, non paragonabile a nessun originale perché nell’atmosfera digitale si danno solo copie senza immagini (come anticipò Benjamin per la sua epoca di riproducibilità tecnica). E quindi, chi e come verificare la “bontà” di quanto circola sul web, di quanto ci informano i social informativi, della qualità e quantità di realtà vera che emerge dal profluvio di dati, immagini e quant’altro gira vorticosamente sul web senza nessun lavoro di intermediazione professionale?
In ultima analisi, ciò che le tecnologie digitali, e la sua punta di diamante oggi, l’IA, mettono a repentaglio è proprio la soggettivazione dell’umano attraverso cui passa ed è passata la storia delle civiltà e i conflitti politici e sociali tesi alla sua forma organizzata, alla sua istituzione destituente quale è la pratica anarchica della lotta al dominio. Ciò che le tecnologie digitali, e la sua punta di diamante oggi, l’IA, mettono a repentaglio è proprio l’ethos fisico e corporeo in cui intrecciare le sperimentazioni in fatto di conflittualità tesa all’allargamento degli spazi di libertà. Contrariamente a quanto si pensi, le Big tech non operano solamente come attori del capitale altamente tecnologizzato, essi sono attori statuali al di qua della loro “discesa” nel campo della politica e del governo, essi sono già attori governamentali – per riecheggiare un termine foucaultiano – direttamente quando è lo Stato accentratore a reggere le fila (Cina, Russia tra gli altri) o indirettamente quando l’élite politica e l’élite algocratica stringono un patto d’acciaio (al di là delle baruffe altalenanti tra Trump e Musk). Il controllo statuale derivato dall’elaborazione dei dati da accumulare e profilare oltrepassa a dismisura ogni scenario orwelliano, proprio perché l’occhio che spia e ci controlla non è esterno al nostro habitat, bensì interno, in una tasca o in una borsa, ma soprattutto internalizzato come diaframma permanente del nostro stare al mondo.